Il lavoro delle sarte, nei laboratori e a domicilio
di Mirella Mingardo
Tra gli anni Settanta e Ottanta del diciannovesimo secolo la Lombardia visse una rapida trasformazione nelle sue tradizionali strutture economiche; artefice, in primo luogo, la politica 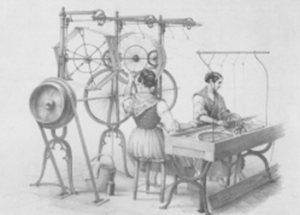 protezionistica voluta dagli industriali milanesi. Nel corso di quei decenni l’espansione industriale fu di dimensioni tali da determinare, in settori come il tessile – dove la grande disponibilità di forza-lavoro permetteva di compensare le insufficienze
protezionistica voluta dagli industriali milanesi. Nel corso di quei decenni l’espansione industriale fu di dimensioni tali da determinare, in settori come il tessile – dove la grande disponibilità di forza-lavoro permetteva di compensare le insufficienze  tecnologiche e di mercato – il passaggio dalla manifattura alla fabbrica meccanizzata.Gli operai e le operaie che sostennero fin dall’inizio lo sforzo produttivo, vissero in condizioni quasi sempre intollerabili: la giornata lavorativa toccava le 15-16 ore nella stagione estiva e la disciplina era quasi militaresca; il cottimo influiva sul salario e lo sfruttamento non risparmiava, come è noto, donne, ragazzi e bambini a partire già dai 4 – 5 anni, sia negli stabilimenti che nel lavoro a domicilio.
tecnologiche e di mercato – il passaggio dalla manifattura alla fabbrica meccanizzata.Gli operai e le operaie che sostennero fin dall’inizio lo sforzo produttivo, vissero in condizioni quasi sempre intollerabili: la giornata lavorativa toccava le 15-16 ore nella stagione estiva e la disciplina era quasi militaresca; il cottimo influiva sul salario e lo sfruttamento non risparmiava, come è noto, donne, ragazzi e bambini a partire già dai 4 – 5 anni, sia negli stabilimenti che nel lavoro a domicilio.
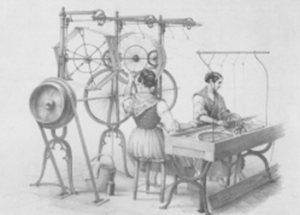 protezionistica voluta dagli industriali milanesi. Nel corso di quei decenni l’espansione industriale fu di dimensioni tali da determinare, in settori come il tessile – dove la grande disponibilità di forza-lavoro permetteva di compensare le insufficienze
protezionistica voluta dagli industriali milanesi. Nel corso di quei decenni l’espansione industriale fu di dimensioni tali da determinare, in settori come il tessile – dove la grande disponibilità di forza-lavoro permetteva di compensare le insufficienze  tecnologiche e di mercato – il passaggio dalla manifattura alla fabbrica meccanizzata.Gli operai e le operaie che sostennero fin dall’inizio lo sforzo produttivo, vissero in condizioni quasi sempre intollerabili: la giornata lavorativa toccava le 15-16 ore nella stagione estiva e la disciplina era quasi militaresca; il cottimo influiva sul salario e lo sfruttamento non risparmiava, come è noto, donne, ragazzi e bambini a partire già dai 4 – 5 anni, sia negli stabilimenti che nel lavoro a domicilio.
tecnologiche e di mercato – il passaggio dalla manifattura alla fabbrica meccanizzata.Gli operai e le operaie che sostennero fin dall’inizio lo sforzo produttivo, vissero in condizioni quasi sempre intollerabili: la giornata lavorativa toccava le 15-16 ore nella stagione estiva e la disciplina era quasi militaresca; il cottimo influiva sul salario e lo sfruttamento non risparmiava, come è noto, donne, ragazzi e bambini a partire già dai 4 – 5 anni, sia negli stabilimenti che nel lavoro a domicilio.Al di là della forte presenza femminile nei servizi domestici, la percentuale delle donne occupate nell’industria, a Milano, all’inizio del secolo, era considerevole, la più alta del Paese, con un maggiore concentramento nel settore del vestiario e dell’abbigliamento (44,73%), e in quello tessile (16,64%)[1].
In quest’ambito un posto importante spettava al lavoro a domicilio. Va precisato che il lavoro nelle abitazioni non era un’attività ai margini del sistema produttivo, ne era al contrario una parte importante[2], e veniva effettuato contemporaneamente o in alternanza con la produzione del laboratorio centralizzato. Era un tipo di lavoro che all’occorrenza poteva estendersi ad altri componenti della famiglia, tra cui i minori, e in taluni casi a persone esterne, riproponendo gli schemi organizzativi che erano tipici del laboratorio.
 Alcune rinomate ditte milanesi come Haardt e figli, Otto Kellental, Prandoni, Ventura e C. insieme agli stabilimenti attivi nella lavorazione degli accessori e ai noti Magazzini Bocconi (in futuro “La Rinascente”) potevano contare sul contributo di numerosissime braccia impegnate nel lavoro a domicilio. In città, nel 1880, secondo quanto affermava anche il foglio “La Lotta”, vi erano non meno di seicento sartorie, comprese le minuscole, che rimanevano aperte almeno 12 ore al giorno.
Alcune rinomate ditte milanesi come Haardt e figli, Otto Kellental, Prandoni, Ventura e C. insieme agli stabilimenti attivi nella lavorazione degli accessori e ai noti Magazzini Bocconi (in futuro “La Rinascente”) potevano contare sul contributo di numerosissime braccia impegnate nel lavoro a domicilio. In città, nel 1880, secondo quanto affermava anche il foglio “La Lotta”, vi erano non meno di seicento sartorie, comprese le minuscole, che rimanevano aperte almeno 12 ore al giorno.L’attrazione esercitata dall’attività del cucito, sin dalla fine degli anni Sessanta, su un numero sempre maggiore di donne, soprattutto giovani, era legata sia all’incremento della domanda per l’espansione dei consumi, sia al processo di industrializzazione in atto, grazie alla macchina da cucire, da poco inventata.
Con l’introduzione della nuova tecnologia, l’antica mansione del sarto venne parcellizzata, frantumata in tanti mestieri specializzati: colletti, busti, guanti, ecc., affidati sempre più spesso all’esterno del laboratorio, cosicché, attorno ad una produzione meccanizzata ruotava solitamente l’opera isolata di innumerevoli mani. L’adozione della macchina ebbe nell’immediato inevitabili ripercussioni negative sul mercato del lavoro, provocando disoccupazione fra le cucitrici e le sarte, che subivano la concorrenza del nuovo congegno, e di riflesso carenza di personale qualificato.
In aiuto alle donne che dovevano imparare a cucire per assicurarsi di che vivere, l’Associazione generale di mutuo soccorso e di istruzione delle operaje di Milano e sobborghi, Sezione femminile dell’Associazione generale degli operaj, voluta da Laura Solera Mantegazza, destinava, nel 1862, Tremila lire alla fondazione di una «Scuola per la cucitura a macchina», la prima del genere a Milano. Furono tuttavia gli industriali a dare maggiore impulso alla diffusione delle macchine da cucire, e quindi al lavoro svolto tra le mura domestiche; essi non solo fornivano i pezzi da confezionare, ma acquistavano direttamente i macchinari alle operaie, rateizzandone l’importo sul lavoro ultimato. Questa pratica incatenava le cucitrici a un determinato indus triale e sollevava quest’ultimo dal problema delle spese strutturali, del licenziamento e della “morta stagione”, che riguardava tutto il settore della confezione.
triale e sollevava quest’ultimo dal problema delle spese strutturali, del licenziamento e della “morta stagione”, che riguardava tutto il settore della confezione.
 triale e sollevava quest’ultimo dal problema delle spese strutturali, del licenziamento e della “morta stagione”, che riguardava tutto il settore della confezione.
triale e sollevava quest’ultimo dal problema delle spese strutturali, del licenziamento e della “morta stagione”, che riguardava tutto il settore della confezione.Lo stretto rapporto tra abitazione e laboratorio non era quindi occasionale, ma era legato ad una precisa strategia imprenditoriale che mirava ad una riduzione generale dei costi, grazie al risparmio negli impianti e al ricorso a maestranze dal basso potere contrattuale. Le stesse dipendenti dei laboratori – definiti “scuole” per le giovani apprendiste – venivano utilizzate nel lavoro a domicilio ogni qualvolta il profitto e l’urgenza richiedevano di ultimare i capi di abbigliamento nelle singole abitazioni, a spese del riposo.
Per poter lavorare le donne erano costrette a organizzare la propria attività in misere e anguste stanze che si trasformavano all’occorrenza in piccoli laboratori, peggiorando ulteriormente il già precario stato igienico delle abitazioni. I modesti ambienti venivano completamente sacrificati al mestiere e i figli, utilizzati come fattorini nelle commissioni più urgenti, venivano costretti a disertare la scuola.
Nei poveri alloggi la tubercolosi era molto elevata e colpiva soprattutto le donne dalla prima fanciullezza ai trent’anni. Tutto il settore legato al vestiario viveva però questa piaga: dalle modiste, alle sarte, dalle cucitrici alle guantaie. Inoltre, le posizioni scorrette che le lavoranti erano costrette assumere, per tempi prolungati, erano la causa di altre malattie professionali: anemie e dolori nelle regioni addominali e ai reni.
I salari delle sarte non erano molto diversi da quelli percepiti dalle operaie delle altre categorie; erano bassi e, come sempre, più bassi di quelli già miseri dei compagni, alle cui prestazioni veniva tuttavia attribuito un valore maggiore. Mediamente, nel settore del vestiario, i compensi erano compresi in un’unica fascia che andava da meno di 1 lira a lire 1.50 al giorno.[3] L’uso del cottimo, adottato sia a domicilio che nei laboratori, contribuiva a tenere basso il livello generale delle retribuzioni e a incrementare la disoccupazione; era inoltre elemento di divisione tra i sessi per la concorrenza che il sistema metteva in moto.
Nell’attività svolta a domicilio il lavoro veniva tra l’altro gravato da spostamenti e attese: la sarta, o il sarto (non era, e non è solo un lavoro femminile), ritirava la stoffa già tagliata, preparava l’abito, unendo le varie parti, e si recava al laboratorio per provarlo al cliente. Spesso una prova non era sufficiente, cosicché parecchie ore venivano sprecate in modo improduttivo.
Ottenere dei capi da rifinire in casa era un’operazione sfibrante, condizionata dalla concorrenza talvolta sleale dei colleghi. Così “Il Sarto”, organo della Federazione di categoria, sintetizzava la «via crucis» di un lavorante costretto ad andare «a caccia di un vestito»: «la mattina alle 8 si presenta dal tagliatore per vedere se vi è lavoro tagliato e molte volte questo o perché occupato, o perché non ha potuto tagliare, gli risponde: tornate più tardi; ritorna dopo un paio d’ore, ed il vestito è già passato ad un altro operaio più astuto; egli non può protestare perché altrimenti perde la bottega e così è costretto ad odiare il proprio compagno più furbo di lui, perché gli ha portato via la preda».[4]
Oltre a queste complicazioni, i lavoratori a domicilio si trovavano in condizioni di inferiorità anche perché gravati dalle spese per l’affitto, per l’illuminazione, il riscaldamento e il carbone per i ferri da stiro, a tutto vantaggio dei proprietari. Ma non bastava. Nei periodi di “morta stagione” erano obbligati a far ricorso alla figura del mediatore che riduceva ulteriormente le già misere paghe. Questi personaggi, che si ponevano come parassiti tra il capitalista e l’operaio salariato, raccoglievano le ordinazioni e le distribuivano agli addetti a domicilio, stabilendo tempi e compensi.
 Per le sarte l’accesso al mestiere era ovunque lo stesso: la bambina veniva avviata al lavoro presso una sarta “in proprio” che poteva essere una vicina di casa o un’amica della madre (le sarte, sempre alla ricerca di manodopera, insegnavano volentieri a cucire alle ragazze in cambio di tre anni di lavoro gratuito); successivamente, entrava nei laboratori come «piscinina» o «piccinina», incaricata a raccogliere spilli, a consegnare i pacchi ai clienti e a fare commissioni. Dopo questa dura e snervante gavetta, la ragazzina poteva essere ammessa con il grado di “seduta” e al successivo livello che comprendeva la cucitura degli orli. Raramente le giovani apprendiste venivano introdotte in sartoria dopo una formazione completa, pertanto bisognava “rubare con l’occhio” i segreti del mestiere, come si legge in numerosi saggi e testimonianze.
Per le sarte l’accesso al mestiere era ovunque lo stesso: la bambina veniva avviata al lavoro presso una sarta “in proprio” che poteva essere una vicina di casa o un’amica della madre (le sarte, sempre alla ricerca di manodopera, insegnavano volentieri a cucire alle ragazze in cambio di tre anni di lavoro gratuito); successivamente, entrava nei laboratori come «piscinina» o «piccinina», incaricata a raccogliere spilli, a consegnare i pacchi ai clienti e a fare commissioni. Dopo questa dura e snervante gavetta, la ragazzina poteva essere ammessa con il grado di “seduta” e al successivo livello che comprendeva la cucitura degli orli. Raramente le giovani apprendiste venivano introdotte in sartoria dopo una formazione completa, pertanto bisognava “rubare con l’occhio” i segreti del mestiere, come si legge in numerosi saggi e testimonianze.Memorabile è rimasto lo sciopero delle “piscinine”: bambine e ragazzine dagli otto ai quattordici che anni protestarono contro le misere paghe, le molteplici mansioni a cui erano adibite, e contro il pesante scatolone che erano costrette a portare, esponendole a gravi conseguenze per lo sviluppo fisico, data la loro età.
Un piccolo esercito di 250 ragazzine si recò, la mattina del 23 giugno 1902, presso i principali stabilimenti per sollecitare le compagne all’astensione dal lavoro e poi, più numerose, si diressero alla Camera del Lavoro; qui venne costituta una commissione di giovanissime sarte e modiste, e steso un memoriale da presentare alle “maestre”. «Questo sciopero – ha scritto Ersilia Bronzini Majno – ha avuto il merito di attirare l’attenzione su uno stato di cose mai abbastanza deplorato, e che doveva proprio giungere al punto di indurre alla ribellione le coscienze infantili, perché se ne accorgessero anche quelli che son ciechi e sordi per elezione».[5]
Per chi vuole approfondire:
– R. Balestri, Mestieri “tradizionali” e donne “spregiudicate”. Le operaie del vestiario a Milano tra lavoro a domicilio e manifattura (1870-1923, “Storia in Lombardia”, n. 1, 1994.
– F. Della Peruta, Lavoro e fabbrica a Milano dall’Unità alla prima guerra mondiale, in Mondo popolare in Lombardia. Milano e il suo territorio, Milano, Silvana, 1985.
– A. M. Galbani, Le scuole professionali delle società operaie di Milano dall’Unità alla fine del secolo, in Milano operaia dall’800 … ,
– V. Maher, Un mestiere da raccontare. Sarte e sartine torinesi tra le due guerre, in “Memoria”, n. 8, 1983.
– L. Malnati, La donna operaia, in Primo congresso di attività pratica femminile. Milano 24-28 maggio 1909, Milano, Società editrice di cultura popolare, 1909.
– S. Merli, Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1890, Firenze, La Nuova Italia, 1972.
– A. Nascimbene, Il movimento operaio in Italia. La questione sociale a Milano dal 1890 al 1900, Milano, Cisalpino Goliardica, 1972.
– Origini, vicende e conquiste delle organizzazioni operaie aderenti alla Camera del Lavoro in Milano, Milano, Ufficio del lavoro della Società Umanitaria,1909.
– S. Ortaggi Cammarosano, Continuità e mutamenti delle forme del lavoro femminile tra XIX e XX secolo, in M. Antonioli, M. Bergamaschi, L. Ganapini ( a cura di), Milano operaia dall’800 a oggi, “Rivista mensile di economia”, serie Quaderni, Milano, Cariplo; Laterza, 1992, vol. 1, n. 22.
– A. Pepe, Movimento operaio e lotte sindacali (1880-1922), Torino, Loescher, 1976.
– E. Sullerot, La donna e il lavoro. Storia e sociologia del lavoro femminile, Milano, Eta Kompass, 1968.
Tutto il materiale iconografico è pubblicato su gentile concessione della Biblioteca Nazionale Braidense e del Ministero dei Beni culturali e ambientali.
E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione.
E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione.
[2] In quei decenni, e a lungo nel tempo, in coincidenza con il matrimonio, oppure con la prima maternità, le donne erano obbligate ad abbandonare il lavoro, o perché licenziate o perché costrette a occuparsi della casa e dei congiunti, trasformandosi, per necessità, in lavoranti a domicilio, alle quali le imprese, perlopiù piccole, decentravano volentieri parte della produzione.















