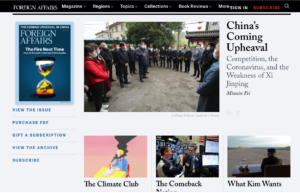di Teo Dalavecuras
Le grandi strategie di politica internazionale sono morte? O nel dibattito tra chi difende i “professionisti” della politica estera e chi considera il loro compito finito si cela la lotta tra i burocrati e i nuovi decisori?
Parlare in termini di “popolarità” di una rivista per studiosi, cultori o attori della politica internazionale come Foreign Affairs suona – ed è – incongruo. Tuttavia, quando si dice che Foreign Affairs non è particolarmente popolare in Europa si vuol dire, in forma abbreviata, che non riflette necessariamente quella parte, non da oggi predominante, dell’opinione pubblica soprattutto europea, che distingue un’America “buona”, quella multilaterale, ispirata ai diritti umani e al politicamente corretto, tendenzialmente “esportatrice di democrazia”, in una parola l’America che secondo la vulgata condivisa 75 anni fa ha salvato l’Europa da se stessa, da quella isolazionista, conservatrice, “repubblicana”. Oggi “trumpiana”. Quell’opinione pubblica, insomma, che si riconosce piuttosto in organi di stampa come il New York Times o in media non cartacei come Project Syndicate, per fare solo due esempi.
Da anni gli studiosi di geopolitica e di relazioni internazionali, perfino nei talk show, si sforzano di spiegare che negli Stati Uniti la politica estera è sostanzialmente “bipartisan”, nel senso che non è né democratica né repubblicana, ma può contare su una maggioranza trasversale tendenzialmente stabile e cospicua. Ma inutilmente. Nei media italiani, quanto meno, il messaggio non passa, la forza dell’abitudine prevale.
Nella guerra ormai senza quartiere tra i sostenitori di Trump e i suoi avversari, l’opinione pubblica europea si schiera con la stessa passione di quella degli States che – almeno in teoria – dovrebbe sentirsi più coinvolta. Perfino Angela Merkel, leader pragmatica se ce n’è una, partendo proprio dai temi di politica internazionale aveva scelto anni fa di polemizzare con Donald Trump; ironia della storia, proprio la Germania ha subito le conseguenze della politica estera dell’America quando nel dicembre dell’anno scorso, con voto bipartisan appunto, il Congresso ha disposto sanzioni contro le aziende costruttrici del “Nord Stream-2”, il raddoppio del gasdotto che trasporta in Germania il gas siberiano.
È facile prevedere che, qualche anno dopo aver proclamato l’esigenza per l’Europa di organizzare autonomamente la difesa dei propri interessi strategici la signora Merkel finirà, in questa fase di acuta disarticolazione del “progetto europeo”, per allineare ancora più di prima la Germania alle posizioni del Paese-guida.
Un indizio in questo senso può sembrare l’avvio, nello scorso aprile e in pieno lock-down da coronavirus, del processo per crimini di guerra nei confronti di Anwar Raslan, responsabile secondo le accuse di avere svolto un ruolo di rilievo negli apparati di sicurezza del regime di Bashir Assad, dove si praticava sistematicamente la tortura, ma dimorante dal 2014 in un campo profughi in Germania.
Di questo nucleo bipartisan della politica estera americana Foreign Affairs è la voce forse più autorevole, così come il Council on Foreign Relations, l’organizzazione della “società civile” (diremmo noi) che la pubblica, fondata all’indomani della Grande Guerra e sede di ricerca, e di confronto interrotto tra esponenti del mondo delle imprese, delle professioni, dell’università e delle istituzioni, insomma dell’establishment, secondo una modalità consueta nel mondo anglosassone, ne è una delle fucine più importanti.
Si parla di Foreign Affairs perché, in una delle ultime edizioni online settimanali, ha pubblicato un saggio firmato da tre studiosi di politica internazionale, tutti noti docenti universitari, Daniel W. Drezner, Ronald R. Krebs e Randall Schweller, che si intitola, tanto per non lasciare nel dubbio i lettori, The End of Grand Strategy (La fine della grande strategia). La composizione del terzetto è interessante, perché mentre Drezner è dichiaratamente anti-trumpiano, Schweller è altrettanto dichiaratamente filo-trumpiano e Krebs non è schierato. Infatti, i tre mettono subito in chiaro che “sono poche le cose su cui ci troviamo d’accordo quando si tratta di politica, di politiche o di ideologia”. Su che cosa sono d’accordo, dunque, i tre studiosi, visto che hanno deciso di firmare lo stesso articolo?
Su una cosa concettualmente semplice che si riassume in una frase: “è finito il tempo delle grandi strategie”.
Per arrivare a questa conclusione, i tre partono dalla disruption trumpiana di quelli che per decenni sono stati i riferimenti di fondo della (bipartisan) politica estera di Washington: internazionalismo liberale, l’idea che l’America debba sostenere e espandere un ordine globale che promuova mercati aperti, sistemi politici aperti e istituzioni multilaterali. L’attacco frontale di Trump a questi “pilastri” ha se non altro alimentato – notano gli autori – un animato dibattito sulle grandi strategie internazionali degli Stati Uniti. Mentre fiorivano questi dibattiti, tuttavia, il concetto stesso della grande strategia sarebbe diventato una “chimera”. Una grande strategia – si fa notare nell’articolo – è una road map che serve a assicurare la coerenza dei mezzi con gli scopi. Funziona al meglio su un terreno noto, in un mondo dove i dirigenti politici possiedono una chiara comprensione della natura e della distribuzione del potere, un robusto consenso all’interno del proprio paese sugli obiettivi e sull’identità comune, stabili istituzioni politiche e altrettanto stabili istituzioni della sicurezza nazionale.
Nel 2020 nulla di tutto ciò esisterebbe più.
Oggi il terreno è ovunque accidentato, gli Stati Uniti sono spaccati e nel mondo il potere è diffuso, frammentato ed è piuttosto potere di interdizione che non potere di realizzare grandi disegni come – si lascia intendere – è stato nei primi decenni del secondo dopoguerra: “quando il potere tradizionale non riesce più a tradursi in influenza, di ordine globale e di cooperazione ce n’è poco”.
In conclusione: “La grande strategia è morta. La radicale incertezza di una politica globale priva di poli la rende meno utile, perfino pericolosa”. “Procedere senza grande strategia vuol dire adottare due principi: decentramento e incrementalismo”, neologismo, quest’ultimo, che sembra significare perseguimento di vantaggi incrementali ovvero del decremento degli svantaggi, in ogni situazione data, rinunciando all’ambizione di capovolgere la situazione stessa.
In parole povere pragmatismo, capacità di adeguarsi a circostanze mutevoli. Perché decentramento? Per l’ovvio motivo che in un mondo imprevedibile e instabile dove le decisioni vanno prese rapidamente, è preferibile che queste siano affidate a chi si trova là dove si manifesta l’esigenza di intervenire.
Nelle parole degli autori, “gli aspiranti consiglieri per la sicurezza nazionale dovrebbero rinunciare a competere per il titolo di prossimo George Kennan. Inventarsi qualcosa che possa prendere il posto della politica del containment (formulata da Kennan nel 1947, ndr) non è né importante né possibile nel prossimo futuro. Far fare passi avanti alla politica estera degli Stati Uniti lo è”.
Il saggio che si è qui ridotto all’essenziale, è naturalmente più ricco e articolato, e contiene valutazioni argomentate in modo persuasivo – questa è almeno l’opinione di chi scrive – ma sempre di valutazioni si tratta. Sono, peraltro, valutazioni che sfociano in esplicite raccomandazioni dirette a quella che in America si chiama la comunità della politica estera e di sicurezza; in buona sostanza, un perentorio invito a prendere atto che il mondo della globalizzazione ispirata ai principi dell’internazionalismo liberale e del multilateralismo non c’è più e si deve, quindi, lavorare concretamente ai miglioramenti possibili di una politica estera considerata insoddisfacente.
Soprattutto, si deve aggiungere, si tratta di raccomandazioni divisive.
Anche se con apparente paradosso, visto che i tre autori dell’articolo solo su queste valutazioni/raccomandazioni si trovano interamente d’accordo, queste sono oggettivamente divisive, come cercherò di argomentare nel prosieguo.
La posizione degli autori e, in particolare, lo scenario del mondo di oggi su cui questa si fonda, comporta un problema non da poco, che prescinde dalla condivisibilità o meno della loro analisi.
Anche se è vero infatti che la visione del mondo globalizzato liberal-democratico e multilaterale ha caratterizzato nella fase “post Guerra Fredda” (e qui di virgolette ce ne vorrebbero tante…) il “comune sentire” degli addetti ai lavori della politica estera e di sicurezza americana, quindi di un ceto professionale almeno teoricamente a-politico e a-ideologico, questa stessa visione è anche qualcos’altro, di fatto ha avuto e ha una precisa funzione: è l’ideologia dell’establishment liberal che non è né nonpartisan né bipartisan, ma dichiaratamente partisan, e attorno a questa ideologia ha costruito un forte consenso transnazionale.
Con questa considerazione si torna all’inizio di questo scritto, ma la considerazione deve essere sviluppata con una non breve digressione di cui mi scuso ma che considero necessaria.
Nessuna ideologia prende la realtà per quello che è, tutte la ricostruiscono in coerenza con gli interessi che la esprimono e gli obiettivi che questi stessi interessi perseguono. Non da oggi si usa parlare di “narrazioni”, perché si dà evidentemente per scontato che l’elettore dei nostri tempi sia regredito a uno stadio infantile e vada quindi alimentato con racconti, ma il concetto non cambia poi molto.
Nelle fiabe, e nelle ideologie, la rivendicazione della coerenza è cruciale.
La narrazione liberal-democratica e globalista è passata dall’annuncio della “fine della storia” (e quindi, in buona sostanza, della politica) proclamata un po’ frettolosamente dopo la caduta del Muro di Berlino, alla denuncia del “sovranismo” quale minaccia incombente sul processo di espansione della democrazia e sulla salvaguardia del processo di globalizzazione.
Il punto debole di questa narrazione non è il significato, pur assai fluttuante, del termine “sovranismo”, che può significare tanto il valore attribuito alla sovranità degli stati, quanto il connotato quasi fatalmente autoritario del culto della sovranità. Spesso le “narrazioni” contengono elementi ambigui.
Il vero punto debole è che in questa visione si dà per scontato e si accetta che alcuni stati, in primo luogo gli Stati Uniti d’America, ma anche la Russia almeno dopo l’avvento di Putin, per non parlare della Cina, dell’India, del Brasile, della Turchia, dell’Arabia Saudita e così via, siano sovrani nel più puro significato westfaliano, e intendano rimanerlo.
Il che fa sorgere inevitabilmente una domanda: quali sono i Paesi rispetto ai quali la rivendicazione di sovranità giustifica l’accusa di “sovranismo”, e perché? Domanda rimasta sinora, e destinata a restare, senza risposta. Almeno in prima battuta.
Nel caso dell’America, l’attributo della sovranità è fuori discussione e si giustifica con la circostanza che gli USA sono il centro da cui il disegno di affermazione della democrazia liberale e di parallela globalizzazione si irradia e questa è anche l’immagine che molti dem americani hanno di se stessi e dell’America, il culto dell’eccezionalismo americano.
Quanto poi alle derive autoritarie che autorizzano a condannare il sovranismo, l’intensità della critica è proporzionale alla distanza del singolo paese dall’ortodossia “occidentale”, sicché le tendenze autocratiche di un Putin sono, di fatto, molto più biasimevoli della propensione di un Erdogan a rinchiudere in gattabuia (nei casi più favorevoli) i giornalisti disallineati, per non parlare di Al Sisi, della famiglia dei Saud e chi più ne ha più ne metta.
Comunque sia la risposta è nei fatti: a dispetto della genericità del termine, il peccato di sovranismo è specificamente quello delle forze politiche dei paesi europei che rivendicano un’antistorica e antieuropea sovranità nazionale.
A prima vista quella ora formulata è una posizione che potrebbe trovare d’accordo quasi tutti, salvo frange estreme di nostalgici o disadattati che debbono dirigere contro qualche obiettivo le loro pulsioni antisistema.
Il fatto è, però, che alla parziale perdita di sovranità degli stati membri non è seguito, né seguirà, verosimilmente, un corrispondente acquisto di sovranità dell’Unione Europea, e a questo riguardo è probante un episodio recente e molto significativo subito rimosso dalla narrazione di ciò che l’Europa è e deve essere.
Ben prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019, il presidente francese Emmanuel Macron (col sostegno anche del governo italiano) aveva proposto che almeno i seggi lasciati liberi dal Brexit, circa un decimo del totale, venissero riservati a una costituenda circoscrizione elettorale europea, così da rappresentare un primo, minuscolo, nucleo di istituzione elettiva legittimata direttamente dai cittadini europei, anziché dalla somma degli elettorati nazionali.
Nel febbraio del 2018 la proposta venne bocciata nell’indifferenza dell’opinione pubblica dallo stesso Europarlamento, che così dimostrò di essere poco interessato alla propria credibilità democratica.
Per concludere, il peccato dei sovranisti europei non è di perseguire una superata e oggettivamente velleitaria rivendicazione di sovranità nazionale ma, tout-court, la pretesa di voler vivere in una comunità politica dotata dell’attributo della sovranità.
Ne è comprova che l’incredibile decisione di qualche mese fa del parlamento ungherese di “autosciogliersi” a tempo indeterminato, dopo qualche polemica sui media è stata “digerita” senza conseguenze. In buona sostanza, in attesa che l’Europa diventi nel 2050 “carbon-free”, si vuole che resti uno spazio “sovereignty-free”, sicché sulle credenziali democratiche degli stati membri bisogna sì essere vigili, ma senza tirare troppo la corda.
Viceversa, il veto francese all’allargamento dell’Ue a Macedonia del Nord e Albania non è stato digerito in alcun modo, anzi ne è stata imposta la implicita revoca, perché in questo caso si tratta di prevenire l’ampliamento della sfera d’influenza russa ai danni di quella dello stato-guida dell’Occidente.
Ancora una volta si tocca con mano come la condanna del sovranismo non sia un leit motiv, ma solo un motivo d’occasione per dare, quando serve, un tocco di internazionalismo liberale al discorso pubblico; un motivo che non pone in discussione la sovranità dei paesi protagonisti del grande gioco della Realpolitik.
Semmai, lo slogan della “democrazia illiberale” lanciato da Victor Orbàn e ripreso da suo mentore Putin conferisce alla retorica che si sviluppa attorno al dilemma sovranismo/antisovranismo un’ulteriore sfumatura di grottesco.
Se la situazione è quella che si è ora cercato di richiamare per sommi capi, è inevitabile che nella narrazione di cui ci si sta occupando il vuoto di sovranità che si è creato in Europa non sia visto negativamente ma al contrario lo si additi come il modello virtuoso di un’area che è definita solo da un sistema di regole e di valori condivisi (Unione europea), che quindi non ha bisogno né di veri confini, né di un vero esercito, né di istituzioni comuni genuinamente politiche.
È, a suo modo, cioè di ripetizione della tragedia in forma di farsa, l’antico sogno marxiano del dissolvimento della politica in amministrazione, che dà a ognuno secondo il bisogno e chiede a ciascuno secondo le possibilità materializzatosi nel tragico ma grandioso esperimento bolscevico.
Perché si parla di modello anche se, a prima vista, questo assetto non è destinato a essere imitato? Forse l’idea sottotraccia, in una dimensione ideologica ma anche programmatica, è che attraverso la pressione del sistema internazionale dei media nel quale questa narrazione è solidamente insediata, e che a propria volta la alimenta, si possa affermare quella sorta di sistema normativo transnazionale che va sotto il nome di “politicamente corretto” e che riesce a imporre regole di condotta legittimate dal loro stigma “progressista”, senza i tempi lenti e macchinosi dell’evoluzione del costume e della giurisprudenza, come richiederebbero i canoni dello stato di diritto, troppo legato peraltro alla storia dello stato sovrano per non essere vittima del medesimo processo di obsolescenza (si noterà che termini come “democrazia parlamentare” sono passati di moda, si preferisce parlare di “modello” liberal-democratico che ha dalla sua una confortevole vaghezza).
In questa prospettiva si può anche capire che l’atroce eliminazione fisica di Jamal Khassoghi nel consolato saudita di Istanbul, così come il sequestro del premier libanese Saad Al Hariri a Riad finiscano sostanzialmente nel dimenticatoio, perché in una prospettiva storica è decisamente più importante che nel regno saudita sia consentita la guida dell’automobile anche alle donne: una posizione non priva di una sua logica, che però postula la sostanziale continuità degli assetti di potere che hanno condotto trentun anni fa alla caduta del Muro di Berlino e quindi al trionfo della globalizzazione a guida americana attraverso strumenti almeno in parte multilaterali.
Se diventasse di pubblica ragione il fatto che questo mondo, come sostengono Drezner, Krebs e Schweller, è tramontato, le crepe nell’impalcatura ideologica di quella che potremmo chiamare la faccia “buona” del globalismo diventerebbero vistose.
Anche perché questa lettura della evoluzione in corso nell’assetto del potere mondiale è condivisa. Per esempio, la condivide una personalità di indiscussa fede liberal-democratica e progressista, come Romano Prodi, che in termini non diversi – nella sostanza – da quelli dei tre studiosi americani, si era espresso pochi mesi fa in una conferenza nella sede milanese dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI); anche se lo stesso professor Prodi, nel colloquio con media più convenzionali come il Foglio e altri, preferisce parlare della liberal-democrazia come del “vaccino” che salverà il mondo dalla minaccia del sovranismo e dell’autoritarismo.
Pur se l’analisi di The End of Grand Strategy fosse condivisibile, se resistesse all’esame di realtà, resterebbe insomma incompatibile con la retorica largamente dominante, quanto meno nel mondo occidentale e certamente in tutti gli apparati in senso lato burocratici (dalle pubbliche amministrazioni alle università agli eserciti ai grandi media alle banche centrali alle grandi multinazionali e in genere le grandi imprese) di questo stesso mondo occidentale.
Detto in forma di slogan: anche se non si può più dire che “la storia è finita”, bisogna seguitare a credere che ci si sta lavorando e ci si arriverà. E nasce il sospetto che sia questa la posta in gioco nello scontro in atto.
Non stupisce quindi che, passata una settimana dalla pubblicazione di The End of Grand Strategy, sempre sul sito di Foreign Affairs (che il suo status nonpartisan lo prende sul serio) altri tre autorevoli professori, Hal Brands, Peter Feaver e William Inboden, abbiano firmato un articolo dal titolo non meno lapidario di quello che si è illustrato più sopra: In Defense of the Blob (In difesa del Blob).
Può essere utile preliminarmente una breve spiegazione del significato di Blob, un termine americano non facilmente traducibile, ma che in questo caso si può rendere con “persone inutili/incapaci”. L’incipit dell’articolo di Brands, Feaver e Inboden, infatti, si riferisce, apertis verbis, al termine (“Blob”) con il quale l’establishment della politica estera americana era stato ridicolizzato, anni fa, da Ben Rhodes, vice consigliere per la sicurezza nazionale durane la presidenza di Barack Obama. Dopo Rhodes, osservano gli autori, “al coro si sono uniti i repubblicani” finché il presidente Trump ha liquidato chi criticava la sua politica estera parlando della “elite fallita di Washington che si preoccupa soltanto di conservare il proprio potere”.
Ma questa è solo la premessa per arrivare a ciò che visibilmente sta a cuore ai tre studiosi: “Su questo punto perfino alcuni dei più aspri critici di Trump nel mondo accademico condividono il suo giudizio”.
L’allusione a Drezner è palese, ma nell’articolo “in difesa del Blob” non c’è ovviamente nessun riferimento al saggio che lo ha preceduto e che intona il De profundis per le grandi strategie, né agli studiosi che lo hanno firmato: non solo nella Vecchia Europa l’accademia ha i suoi riti e i suoi metodi. Al netto di questi aspetti cerimoniali, tuttavia, la contrapposizione è irriducibile, e il titolo è da prendere alla lettera.
The End of Grand Strategy si concentra sul fatto che sia per motivi interni agli States (la spaccatura del paese) sia per motivi esterni (trasformazioni nella natura e nelle dinamiche del potere nel mondo) l’elaborazione di grandi disegni strategici è nel migliore dei casi pura perdita di tempo ma rimane tuttavia la principale occupazione della comunità di esperti cui è affidata la politica estera e di sicurezza, e questo spiega i risultati insoddisfacenti di questa politica negli ultimi anni.
In Defense of the Blob, peraltro, salta a piè pari l’analisi che fa da premessa e si rivolge con grande vis polemica e perfino con sincero pathos alle conclusioni, innanzitutto alla prima di queste, che si compendia nel termine “Blob”: la comunità degli addetti alla politica estera e alla sicurezza nazionale non è affatto una élite autoreferenziale (ma nel testo si parla addirittura di cabal, di conventicola di complottisti, attribuendo ovviamente il termine ai critici dell’establishment).
“L’establishment della politica estera è una risorsa dell’America, non una debolezza”. Più avanti, per chiarire ancora meglio il concetto: “Sia in termini assoluti che in termini relativi, la comunità di esperti che trattano le questioni di politica estera e di sicurezza nazionale negli Stati Uniti è notevolmente ampia e eterogenea…Inoltre, diversamente dalle comunità corrispondenti di altre grandi potenze, l’establishment americano di politica estera non è separato dalla società ma connesso a questa, in quanto gli strati superiori delle burocrazie della sicurezza nazionale Usa sono staffate con personale di nomina politica piuttosto che con funzionari. Il Blob comprende funzionari del governo, esperti esterni, e molte persone che vanno e vengono tra le due sponde”.
Dopo aver difeso con grande convinzione la qualità, l’apertura alla società e la ricchezza del dibattito interno che contraddistingue la comunità degli esperti di politica estera e di sicurezza nazionale, l’articolo si dedica, nella seconda parte, con altrettanta decisione a sviluppare un quadro positivo dei risultati della politica estera americana dei decenni “post-Guerra Fredda”, senza nascondere alcune “delusioni”.
Si legge, per esempio, che “Globalizzazione e democratizzazione dovevano far maturare Cina e Russia e aiutarle a inserirsi facilmente nell’ordine (mondiale, ndr) a guida americana. Non ha funzionato così bene come si era sperato”, e più avanti, tentando di redigere un bilancio del post-Guerra Fredda: “da una parte alcuni fallimenti, dall’altra un successo gigantesco, l’emergere di un sistema internazionale molto più pacifico, prospero e liberale al centro del quale si collocano gli Stati Uniti, sicuri e prosperi”.
Avviandosi alla conclusione, Brands, Feaver e Inboden affrontano di petto quello che sembra essere, ancora più della “difesa del Blob”, il cuore del loro argomento: Trump.
“L’amministrazione Trump ha emarginato i professionisti della sicurezza nazionale, e la professionalità, in una misura senza precedenti nell’era moderna. Il presidente ha regolarmente disatteso il parere dei funzionari di carriera apolitici, li ha accusati di slealtà e perfino di tradimento, e ha epurato dai vertici dell’amministrazione chiunque non fosse disposto a adeguarsi alla linea ufficiale del giorno (quale che fosse). I risultati di questo esperimento non sono incoraggianti. Sinora ha prodotto politiche scadenti, attuate in maniera scadente e con risultati scadenti”.
È interessante che l’articolo, partito dalla rievocazione dell’attacco di un esponente dell’amministrazione Obama, Ben Rhodes, alla burocrazia, o tecnocrazia, delle relazioni internazionali e della sicurezza, si concluda con una requisitoria nei confronti dell’amministrazione Trump che avrebbe introdotto una gestione capricciosa e non professionale di queste stesse relazioni.
Ci si potrebbe chiedere se la vera ragione del contendere sia il contenuto della politica estera o di sicurezza Usa o non sia piuttosto l’identità del soggetto che la determina: al netto delle accuse di stile despotico, che non è questa la sede di valutare, l’alternativa è tra un decisore politico, oppure un apparato tecnico-burocratico che elabora scenari, sulla base degli scenari elabora strategie e procedure per attuarle.
La prima alternativa sembrerebbe più compatibile con la posizione di The End of Grand Strategy, la seconda è quella esplicitamente raccomandata dagli autori di In defense of the Blob. E la seconda è incompatibile col riconoscimento del ritorno della Realpolitik nelle relazioni internazionali, una conseguenza del fallimento del tentativo di “assimilare” in modo non conflittuale i sistemi non ancora omogenei alla comunità occidentale (dove “occidentale” si riferisce non alla geografia, naturalmente, ma alle sfere d’influenza politica) come la Russia post-Eltsin e la Cina.
Il caparbio rifiuto di dare ingresso, nel discorso pubblico del mondo occidentale, all’ovvia verità che gli attori del gioco politico internazionale sono soggetti sovrani e non incorporee istituzioni multilaterali, ricorda però – e questo è inquietante – le “pie banalità” in materia di liberalismo e umanesimo di cui parla Hannah Arendt in Le origini del totalitarismo (citato da Tim Schenk su Tablet Magazine del 6 dicembre 2018), a proposito dell’attrazione dei giovani intellettuali tedeschi per Hitler al momento dell’ascesa al potere, e questo sento il dovere di dirlo senza nascondermi dietro un’imparzialità di facciata.
Comunque sia, tre cose sembrano chiare.
La prima, che tra le due opzioni rappresentate dai due saggi commentati in questo articolo, è in corso uno scontro senza quartiere che, benché focalizzato principalmente sulla politica estera e di sicurezza investe, in realtà, i fondamenti del governo, l’alternativa tra il governo legittimato dal consenso e il governo legittimato dalla competenza: una contrapposizione di cui non sfuggirà la connotazione “sovrastrutturale” e di cui sarebbe interessante esplorare i fondamenti “strutturali”, considerato da un lato che le burocrazie che si confrontano con la leadership politica sono a pieno titolo una classe sociale, anzi la classe sociale che sinora, nella storia, non ha mai perso nessuna battaglia; dall’altro lato che l’alternativa tra la decisione (inevitabilmente “responsabile” in quanto riconducibile a un autore) e l’esecuzione di una procedura (per propria natura irresponsabile perché riconducibile a una regola), una volta posta diventa irriducibile, e sembra che ormai questa sia l’alternativa sul tappeto.
E mi chiedo se dopo la rivoluzione del proletariato (1917), dopo la rivoluzione dei manager (1941) non si avvicini il momento della rivoluzione dei funzionari.
Che altro è la polemica contro il sovranismo, in ultima analisi e a prescindere dal suo uso strumentale, se non la contestazione della ineludibile presenza, in uno stato sovrano e proprio perché sovrano, di un potere di ultima istanza sovraordinato a tutte le posizioni gerarchiche in cui si materializza la struttura dello stato?
La seconda, che questo scontro, che conserva il suo epicentro nella potenza-guida, gli Usa, si ripercuote inevitabilmente sugli equilibri dei paesi del resto del mondo, che non possono non schierarsi: e se lo fanno in una logica di alleanze (e di potenza relativa) gli attori sovrani della scena internazionale, sono costretti a farlo a rimorchio di logiche lobbistiche le aree contraddistinte da un vuoto di sovranità, e si sta pensando – è ovvio – all’Europa.
La terza, che “leggere” lo scontro nei termini attualmente in voga di progressismo (o modello liberal-democratico) versus conservatorismo (modello sovranista) non pare promettente se l’obiettivo è quello di esplorare le ragioni profonde, di lungo termine, dello scontro stesso, e le coalizioni di potere che lo determinano, ma si giustifica solo in una logica “militante”.
Teo Dalavecuras
Tags: democrazia, democrazia liberale, europa, funzionari, Realpolitik, sovranismo, sovranità, Usa